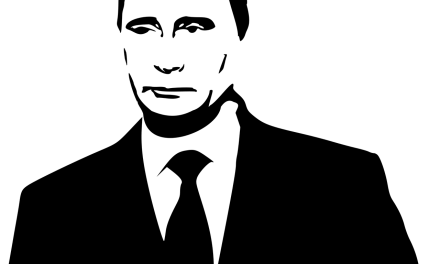Sergio Mattarella – Foto di Martin Schulz da Flickr
Le trattative che hanno preceduto la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica hanno visto alcuni partiti farsi promotori di una candidatura (quella dell’ambasciatrice Elisabetta Belloni) ispirata ad un’idea della carica molto diversa da quella del disegno costituzionale, espressa nelle figure dei dodici predecessori. Nata e tramontata in poche ore, prima ancora di concretarsi in proposta al Parlamento, questa ipotesi avrebbe costituito un precedente tanto paradossale quanto rischioso, e non solo per la tendenza che ha sempre da noi l’eccezionale (come la rielezione di un P.d.R.) a farsi rapidamente canonico. Le dimissioni di Luigi Di Maio dal Comitato di garanzia del M5S sono probabilmente solo la prima delle conseguenze politiche di questa vicenda, conclusasi lasciando formalmente le cose come stavano, ma con più di un graffio al quadro politico.
Con le principali forze in campo giustamente decise a garantire la stabilità di governo, e convinte che la riluttanza di Mattarella avrebbe potuto essere forzata con ovvie probabilità di successo (come avrebbe potuto sottrarsi?), la conclusione della vicenda non ha stupito nessuno. Certo non chi abbia un minimo di frequentazione di giornali e social. Lo sbriciolamento dei gruppi parlamentari avvenuto in questi quattro anni, con la nascita di un abnorme gruppo misto – una sorta di legione straniera in grado di terremotare qualunque tipo di soluzione non unanimistica – ha prodotto un effetto alla Jep Gambardella, il protagonista della “Grande bellezza”: quello orgoglioso non tanto dell’invito a una festa quanto del potere di farla fallire. Nessuna alleanza politica era in grado di avanzare la candidatura di un proprio candidato; tutte lo erano di “bruciarne” una non gradita. Il famoso proclama “non accetteremo veti”, in una situazione in cui l’unica carta in mano ai soggetti politici coinvolti era il diritto di veto, dà l’idea della statura politica del banditore. Davanti a questo stallo, alcuni dei principali soggetti di questa stracca trattativa hanno tentato – non so quanto credendoci veramente – la via di fuga più praticata in questi casi: la via del “tecnico”. Che queste forze siano quelle che più esecrano, a parole, i governi tecnici – in nome del primato della politica e della sovranità popolare – è solo la prima delle paradossalità della vicenda. Si può discutere all’infinito su questi governi – che non sono mai davvero tecnici e che finora hanno avuto al comando “tecnici” molto politici, da Ciampi a Prodi, da Monti a Draghi) ma può un tecnico (e senza virgolette, come la dottoressa Belloni) aderire alla figura costituzionale del Presidente della Repubblica? Per me no. E non solo adesso che ce n’è già uno al governo. Sarebbe come eleggere Papa il funzionario capo della segreteria vaticana, solo perché nel suo ambito è una figura di eccellenza. Non funzionano in questo modo le cose.

Elisabetta Belloni – Foto di Υπουργείο Εξωτερικών (CC BY-SA 2.0)
Elisabetta Belloni è persona nota all’interno della comunità di TUTTI, gode di affetto e stima. Stima che è quella, unanime, di chiunque l’abbia conosciuta nel corso di una bellissima carriera di “civil servant”. Prima al Ministero degli Esteri, di cui è stata Segretario Generale, poi, da otto mesi, alla direzione dei servizi segreti. Ma non è un segreto (a proposito) per nessuno – e tanto meno un’offesa, semmai un riconoscimento – che il suo nome, come i tratti della sua figura istituzionale, fossero per lo più ignoti anche alla maggior parte di coloro che avrebbero dovuto votarla (i cosiddetti “grandi elettori”); tanto più lo erano – al netto di qualche affannosa ricerca su Wikipedia – alla quasi totalità degli italiani. Per cui la prima domanda (nessuno la consideri banale) è: può un impolitico (e nessuno, per definizione, lo è più di un ambasciatore), tanto più di notorietà limitata al suo ambito professionale, diventare P.d.R.? Essere chiamato, cioè, a rappresentare l’unità nazionale (sciogliere le Camere, presiedere il CSM, guidare le FF AA e quant’altro previsto in Costituzione)? Può il rappresentante dell’unità nazionale essere un italiano (uomo o donna, vi prego, esimetemi dall’o/a in tutte le cinquanta occasioni che si presenteranno) di cui 999 italiani su mille ignorano praticamente tutto? Uno che se lo incontri per strada, come in un celebre monologo di Gaber, può dirti, giustamente: “Lei non sa chi sono io”? C’è qualcuno che non veda come la fortissima carica simbolica e l’autorità morale connesse al ruolo consiglino (anzi, impongano) di rifiutare una tale impostazione? E non è, infine, un divertente paradosso politico il fatto che tra i promotori della candidatura di cui parliamo ci fossero i fautori più strenui di un Presidente eletto a suffragio universale, quindi dalla forte identità politica e dall’ancor più forte legame con i cittadini?
Pur prevedendo la possibilità per qualunque cittadino che abbia compiuto cinquant’anni di diventare Capo dello Stato, la nostra Costituzione fornisce un identikit assolutamente politico della carica, disegnandola nei fatti come il punto d’arrivo di un’importante carriera politico istituzionale. Così l’hanno interpretata finora tutti i parlamenti repubblicani. Ad essa hanno aderito le figure dei dodici Presidenti che si sono succeduti nella carica – secondo quell’unica, singolare, idea di alternanza che siamo riusciti a realizzare in ottant’anni: quella fra un Capo dello Stato “cattolico” e uno “laico”. Dove cattolico significa “democristiano” e laico “resto del mondo”. Un resto del mondo liberale negli anni ’50 (Einaudi), socialdemocratico nei sessanta (Saragat), socialista nei settanta (Pertini), azionista nei novanta (Ciampi, passo indietro e nello stesso tempo avanti nella lunga marcia di avvicinamento dell’ex PCI alle istituzioni), fino a Napolitano nel 2000. Un filo che, con i suoi alti e i suoi bassi, racconta la storia d’Italia, signori, e in cui si riflette il rapporto fra il popolo e la sua rappresentanza. Pur senza rifarsi ai principi della repubblica presidenziale, la nostra Costituzione esclude del tutto una concezione “funzionariale” della carica di Capo dello Stato, a partire dalla composizione di quel particolarissimo collegio elettorale, che unisce poteri centrali e locali. Rappresentanze nazionali e regionali di quell’unico popolo che si intende rappresentato anche in questa funzione.

Ingresso del Palazzo del Quirinale – Foto di Alex Barrow da Flickr
Tutto questo premesso, l’argomento più forte portato all’ipotesi di candidatura Belloni è stato, come ognuno sa, la sua provenienza dalla direzione dei servizi segreti. Argomento serissimo, non perché il direttore del DIS sia un agente segreto (anche se il ruolo, prima di lei, era stato abituale appannaggio di militari), ma perché, anche se non incompatibile per legge, il passaggio dall’una all’altra delle due funzioni è considerato inconcepibile, con giusta ragione, in ogni democrazia occidentale. E anche qui, che fra i sostenitori del passaggio indolore da una funzione all’altra (“che sarà mai?”) ci fosse un ex presidente del Consiglio (Giuseppe Conte) che solo un anno prima a quel ruolo – oggi della dottoressa Belloni – aveva destinato un generale di divisione della Guardia di Finanza (Gennaro Vecchione), è una simpatica, ulteriore, paradossalità. Anche lui sarebbe andato bene come Presidente?
Ma per quanto interessanti siano i problemi teorici che solleva, non è neanche il caso adesso di farla troppo lunga, con questa vicenda durata “l’espace d’une nuit”. Prima ad esserne convinta è parsa essere l’ambasciatrice stessa. Legata da stima e amicizia a Luigi Di Maio, che aveva contribuito a far fallire la sua candidatura, non ha fatto attendere un solo giorno il suo sostegno al ministro nella tempesta; ben guardandosi, per contro, dal ringraziare chi l’avrebbe voluta Capo dello Stato. Dal che sembra di poter dedurre che non sia stata nemmeno consultata da chi aveva così temerariamente speso (e non solo nelle segrete stanze) il suo nome in quelle ore. Nota genuinamente umoristica sul carattere di questa trattativa – e dei due Bibì e Bibò che l’hanno condotta – ideale per concludere in allegria il pezzo.