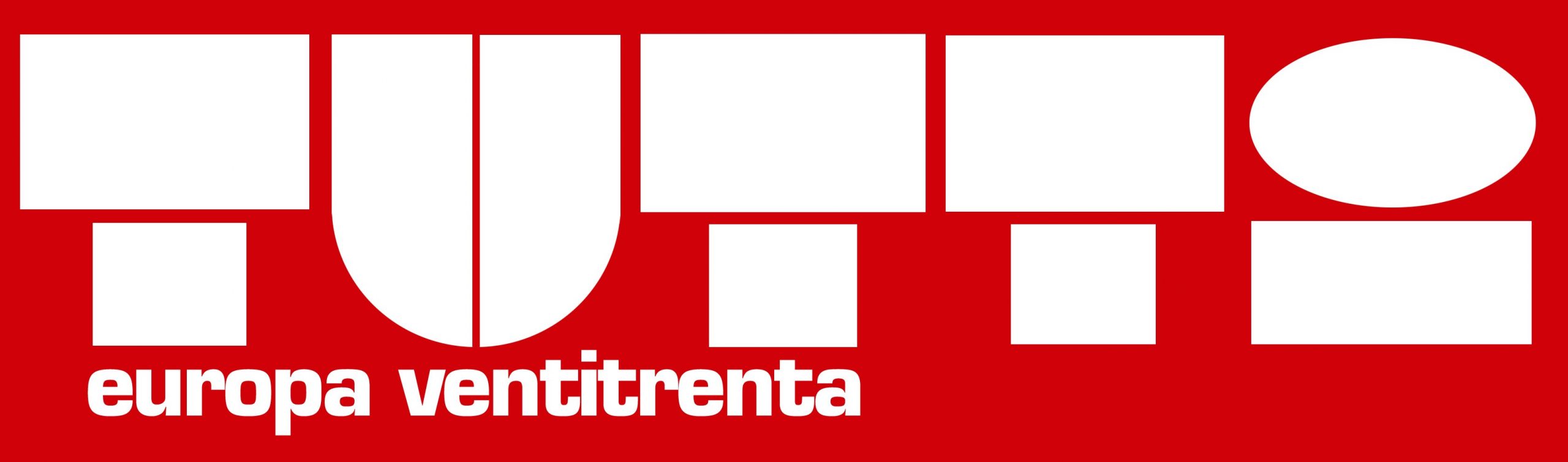Sono passati 1.000 giorni dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia. Oggi le accuse contro l’Ucraina sono sempre più frequenti, con cifre enormi per il “denaro speso per l’Ucraina”, affermazioni secondo cui “nessuno deve nulla all’Ucraina” – sottintendendo che gli altri Paesi non hanno alcun obbligo di assistenza – e titoli come “Gli Stati Uniti spingono l’Ucraina ad abbassare l’età di combattimento a 18 anni per rafforzare i ranghi contro la Russia” (!). Tuttavia, pochi ricordano che sono stati gli Stati Uniti a fare pressione sull’Ucraina affinché rinunciasse al suo arsenale nucleare (il terzo più grande arsenale nucleare al mondo!) – un arsenale che avrebbe potuto proteggerla da un attacco russo.
Questo mese, il 5 dicembre 2024, ricorre il 30° anniversario della firma del Memorandum sulle garanzie di sicurezza in relazione all’adesione dell’Ucraina al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, noto anche come Memorandum di Budapest.
Abbiamo chiesto a una specialista nel campo del diritto internazionale ed europeo di fare luce su questo argomento per i lettori di TUTTI Europa 2030.
Iryna Medved
Inizio anni ’90… Il mondo è in uno stato di euforia. Il muro di Berlino è caduto, la guerra fredda è finita. Il sistema di sicurezza globale bipolare è crollato. Sulla scena internazionale, emergono rapidamente alcuni nuovi Stati indipendenti, ex repubbliche dell’URSS. Sembra che davanti a noi ci siano prosperità economica, armonia, pace e una nuova era di rinascita globale. Decenni di pericolosi scontri tra le due superpotenze nucleari, la crisi dei missili di Cuba, appartengono ormai alla storia con un lieto fine.
Tuttavia, il mondo rimane sovraccarico di armi nucleari. Il ricordo della terribile catastrofe di Chernobyl è ancora fresco.
Il collasso dell’URSS, fra gli altri problemi, provocò l’emergenza della nascita di nuovi stati con armi nucleari, quelli dove tali armi erano allocate. Fra questi l’Ucraina aveva una posizione speciale in quanto possedeva un arsenale nucleare terzo per ampiezza dopo quelli di USA e Russia. Pertanto il problema di rafforzare il controllo sulla proliferazione nucleare divenne particolarmente rilevante anche in funzione dello scenario più ottimistico: la denuclearizzazione.
Nel 1965, durante la Conferenza sul disarmo di Ginevra, fu messo a punto il draft del Trattato di Non-proliferazione delle armi nucleari (NPT) che poi fu ufficializzato il 5 marzo 1970 con la firma di 43 stati, fra i quali tre potenze nucleari: USA, URSS e Regno Unito. Per un lungo periodo vi furono nel mondo solo cinque stati con armi nucleari: i tre citati più Cina e Francia; tutte le altre nazioni erano considerate non-nucleari.
L’eredità nucleare dell’Ucraina: un dilemma legale
Lo status nucleare dell’Ucraina, in quanto Paese con un’economia debole e un quadro giuridico obsoleto e inefficiente, ha indubbiamente rappresentato una sfida al sistema di sicurezza internazionale esistente. Nonostante l’Ucraina fosse uno dei membri fondatori delle Nazioni Unite e partecipasse attivamente al lavoro dei suoi organi primari e delle sue istituzioni ausiliarie, sulla scena globale la Repubblica Socialista Sovietica Ucraina – e in seguito lo Stato che le è succeduto, l’Ucraina – non era in generale considerata un attore indipendente.
L’immagine controversa dell’establishment politico ucraino dell’epoca – che ereditava in gran parte le tradizioni e i metodi di governo dell’era sovietica – insieme alla mancanza di un piano chiaro e coerente per le riforme politiche ed economiche, non incoraggiavano le potenze internazionali a considerare l’Ucraina come un partner credibile e indipendente.
Al contrario, la Federazione Russa è stata vista a priori come l’incarnazione delle dimensioni e della potenza dell’ex Unione Sovietica. Purtroppo, questa percezione ha incoraggiato e sostenuto il comportamento audace e sicuro della Russia. Sebbene giuridicamente la Russia fosse il diretto successore solo della Repubblica Socialista Sovietica della Russia, di fatto rivendicava la piena continuità della posizione dell’URSS sulla scena internazionale. La manifestazione più evidente è stata l’assunzione unilaterale del seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il principale organo responsabile della sicurezza globale.
In questo contesto, lo status nucleare dell’Ucraina è stato visto come una sfortunata e pericolosa dimenticanza che doveva essere corretta il prima possibile, attraverso pressioni politiche e grandi promesse. L’Ucraina, d’altra parte, non aveva le risorse per impegnarsi in una seria contrattazione politica e valutava realisticamente i pericoli del mantenimento di armi nucleari obsolete e costose. Così, già nel 1992, l’Ucraina si dichiarò disposta a rinunciare al suo status nucleare in cambio di efficaci garanzie di sicurezza internazionali.
Il processo si è rivelato complesso ed è stato accompagnato da intense pressioni sia da parte del vicino più prossimo, la Federazione Russa, sia da parte del suo recente avversario politico, gli Stati Uniti.
Per l’Ucraina, questi impegnativi processi politici rappresentavano una seria minaccia, tra cui il rischio di isolamento politico nel caso in cui si fosse rifiutata di rispettare le condizioni dei suoi partner, il che avrebbe inevitabilmente portato a una grave esacerbazione della crisi economica e messo in discussione la stessa sostenibilità del nuovo Stato indipendente. Inoltre, le armi nucleari allocate in Ucraina non avevano un valore strategico ma solo tattico. Tecnicamente, il loro utilizzo era possibile solo con il consenso diretto della Russia, poiché tutti i centri di controllo erano situati in territorio russo.
Negoziati e Memorandum di Budapest
Tra il 1991 e il 1994 si svolsero una serie di negoziati a livello bilaterale e multilaterale. L’Ucraina propose vari scenari per l’attuazione del processo di disarmo. Tuttavia, nelle fasi finali dei negoziati, la richiesta principale dell’Ucraina è rimasta quella di ottenere dalle potenze nucleari garanzie effettive sulla propria sovranità e integrità territoriale, in conformità con i principi fondamentali del diritto internazionale moderno sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall’Atto finale di Helsinki.
Di conseguenza, il 5 dicembre 1994, l’Ucraina, la Russia, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno firmato il Memorandum sulle garanzie di sicurezza in relazione all’adesione dell’Ucraina al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Successivamente queste garanzie furono riconfermate dalle altre due potenze nucleare, Cina e Francia.
L’adempimento dei termini del memorandum da parte dell’Ucraina si è protratto per diversi anni. Impiegando complesse strategie politiche e mantenendo il processo sotto stretto controllo, la Russia è emersa alla fine come il principale beneficiario dell’attuazione del memorandum. La consapevolezza di questi rischi da parte dell’Ucraina si riflette in uno scambio recentemente declassificato tra il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e il Presidente ucraino Leonid Kuchma. Alla vigilia della firma del memorandum, Kuchma ha dichiarato: “Apprezzo la sua posizione nei confronti della Russia. Nelle circostanze attuali, non possiamo evitare di trattare con loro”.
Così, il Presidente ucraino ha erroneamente interpretato la posizione degli Stati Uniti come un vero e proprio sostegno all’Ucraina nel suo confronto aperto con la Russia. Tuttavia, secondo gli stessi documenti, è stato durante i contatti bilaterali tra Boris Eltsin e Bill Clinton che è stato raggiunto un accordo per fermare l’espansione della NATO, privando di fatto l’Ucraina di reali garanzie di sicurezza.
Come parte dell’accordo, l’uranio altamente arricchito delle testate nucleari doveva essere trasferito in Russia per essere distrutto. In cambio, la Russia si impegnava a fornire all’Ucraina una quantità equivalente di uranio a basso arricchimento da utilizzare come combustibile nelle centrali nucleari. Trasferire l’uranio altamente arricchito alla Russia è stato come lasciare che una volpe facesse la guardia al pollaio. Oggi, la Russia usa proprio le armi consegnate dall’Ucraina come minaccia per dissuadere la comunità internazionale dal fornire all’Ucraina un sostegno sufficiente a contrastare il più grande aggressore dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Il passo finale nell’adempimento degli obblighi da parte dell’Ucraina è stato compiuto dal Presidente ucraino Viktor Yanukovych, poi condannato per tradimento per aver agito a favore dello Stato aggressore. Una delle prime decisioni di Yanukovych come presidente, nel 2010, è stata quella di trasferire l’ultimo lotto di uranio altamente arricchito alla Russia. Da quel momento, il ripristino dello status nucleare dell’Ucraina è diventato praticamente impossibile.
Dove sta la frode?
Per rispondere a questa domanda, è importante valutare obiettivamente la posta in gioco per l’Ucraina e quali potevano essere le sue legittime aspettative come risultato.
“L’arsenale nucleare ucraino consisteva in 176 missili balistici intercontinentali (ICBM), tra cui 130 SS-19 a combustibile liquido e 46 SS-24 a combustibile solido, oltre a 44 bombardieri strategici dotati di missili da crociera, circa 2.000 testate nucleari strategiche e 2.600 armi nucleari tattiche”. (William Potter, “La politica della rinuncia al nucleare: The Cases of Belarus, Kazakhstan, and Ukraine”, Occasional Paper, Stimson Center, aprile 1995).
L’elenco è sbalorditivo! L’Ucraina rimane quindi l’unico Paese al mondo ad aver rinunciato volontariamente a un potente arsenale nucleare.
Cosa ha ricevuto in cambio l’Ucraina?
Innanzitutto, i testi “ugualmente autentici” del memorandum in inglese e in ucraino differiscono dal punto di vista terminologico, persino nel titolo del documento. Secondo la versione inglese, all’Ucraina sono state fornite “assicurazioni di sicurezza”, mentre la versione ucraina parla di “garanzie di sicurezza”. L’uso di “garanzie” nella versione inglese avrebbe implicato l’obbligo di usare la forza militare. Tali impegni avrebbero richiesto la ratifica del Senato degli Stati Uniti. Non è accaduto nulla del genere, come sappiamo.
Recentemente si sono intensificati i dibattiti sulla mancanza di forza vincolante del memorandum. Tuttavia, secondo il diritto internazionale, il titolo di un documento è arbitrario e non determina intrinsecamente la sua natura vincolante o la portata dei suoi obblighi.
È indiscutibile, tuttavia, che il documento manchi di impegni specifici da parte degli Stati garanti. Al contrario, contiene un linguaggio vago sull’obbligo di sottoporre le questioni al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sorpresa! Lo Stato aggressore, che ha violato tutti i principi del diritto internazionale, comprese le disposizioni del Memorandum di Budapest, è, grazie a precedenti macchinazioni, un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In quanto tale, esercita un potere di veto su tutte le sue decisioni – potere che usa attivamente, accusando cinicamente la sua vittima di aggressione contro se stessa.
Un impegno internazionale ignorato
Il Memorandum di Budapest non è un accordo locale o regionale con un oggetto limitato e rilevante solo per i suoi immediati partecipanti. Le armi nucleari sono armi di distruzione di massa e il loro stoccaggio, produzione o proliferazione rappresentano una minaccia diretta per l’intera comunità internazionale, la pace e la sicurezza globale. Inoltre, il peso politico di uno Stato nucleare è criticamente diverso da quello di uno Stato non nucleare.
Non era forse ragionevole per l’Ucraina aspettarsi garanzie effettive piuttosto che semplici assicurazioni di sicurezza in cambio della rinuncia volontaria al proprio arsenale nucleare? La risposta è ovvia.
L’inazione degli Stati garanti del Memorandum di Budapest di fronte all’invasione aggressiva, all’annessione territoriale, alle violazioni delle consuetudini di guerra e alle atrocità – tra cui la tortura, le esecuzioni e l’abuso di prigionieri di guerra da parte di uno dei garanti – allinea gli altri garanti con l’aggressore. Inoltre la cosa più allarmante è che questa situazione da luce verde al terrorismo internazionale e nullifica ogni sforzo per la denuclearizzazione.
Lo slogan “Mai Più” è divenuta una frase vuota. In questo momento è in corso la barbarica distruzione del popolo di un paese europeo. L’Ucraina, che 30 anni fa divenne la prima (in particolare per la quantità di armamenti) e probabilmente l’unica nazione che volontariamente rinunciò alle armi nucleari per ottenere garanzie rivelatesi una finzione giuridica se non una frode deliberata al più alto livello internazionale.

ANNA FASTOVETS – ASSOCIATE PROFESSOR (International law)
Nata a Kiev in una famiglia di fisici. Nel 1999 si è laureata all’Università Nazionale “Taras Shevchenko” di Kiev, Istituto di Relazioni Internazionali. Ha conseguito un Master in diritto internazionale. Ha discusso la Tesi di dottorato su “Il ruolo del rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia europea” (2016). Ha oltre vent’anni di esperienza nell’insegnamento del diritto internazionale ed europeo. Fino allo scoppio della guerra ha lavorato presso l’Università economica nazionale di Kiev, nell’Istituto di diritto. È mamma di 4 figli.