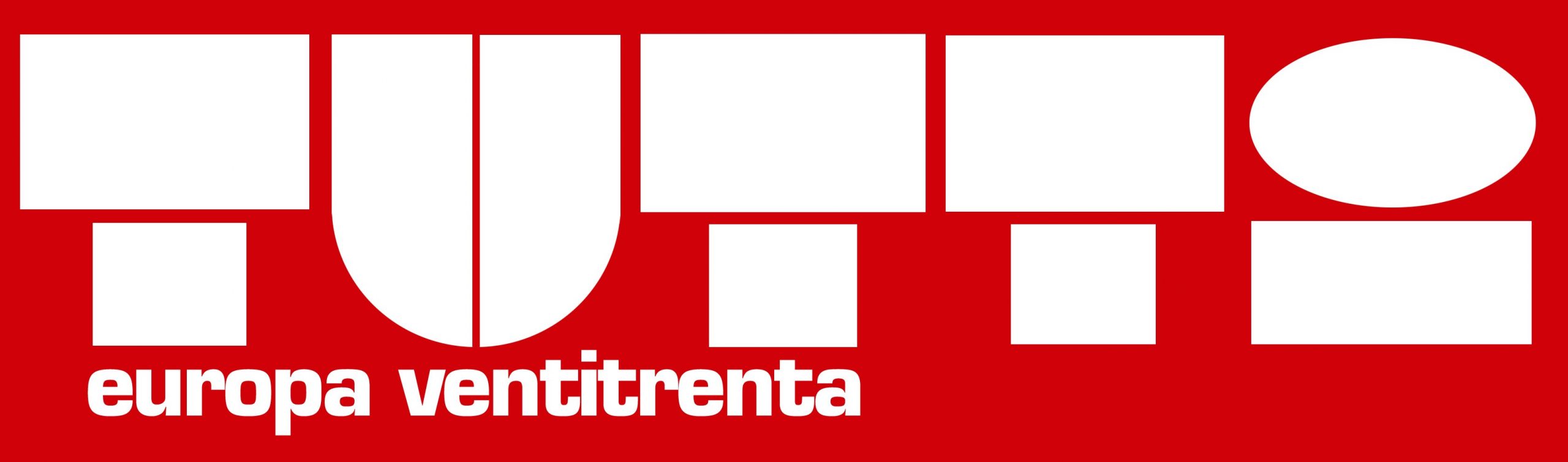Dedicato alla memoria del Prof. Ezio Burri
In questa IV puntata del racconto dei nostri viaggi in Iran per studiare i qanat, ricordiamo i nuovi incontri con le autorità locali e la programmazione delle nostre attività di ricerca incentrate sui qanat, poi parliamo delle misurazioni proprio relative a quello di Shahrood. Buona lettura, continuate ad accompagnarci lungo le strade, i paesi ed i deserti persiani.
Primo pranzo a Shahrood

Miandasht: ingresso del caravanserraglio (foto Pietro Ragni)
Vicino al bazar di cui vi ho parlato nella III puntata, c’è il ristorante dove spesso vanno i professori dell’università e lì abbiamo fatto il nostro primo pasto iraniano con i colleghi che ci avevano accompagnato. Sul tavolo vi erano vari frutti freschi e secchi, soprattutto pistacchi di vari colori e mele, bottiglie di dough e di acqua corrente. Non mancava il pane locale, chiamato “sangak” (il significato etimologico è “cotto sulla pietra”) che è sottile e friabile, un po’ come il pane carasau sardo. Personalmente preferisco invece il “nun barbari”, simile al classico naan indiano, grande come una nostra pizza, ma soffice e lievitato, quello che porteranno per merenda i colleghi che venivano con noi verso le oasi.
Per prudenza avevamo deciso di evitare di bere l’acqua locale. Secondo WHO (Organizzazione Mondiale per la Salute) il maggior numero di malattie, viaggiando, viene contratto da incauti turisti che hanno bevuto acqua di rubinetto. Per non offendere nessuno, chiesi se ci fosse acqua gassata; immediata risposta negativa del cameriere che contropropone la birra locale, ovviamente accettiamo. Si trattava di un liquido gassato, colorato e dolcificato con un sapore inqualificabile! Abbiamo dovuto ripiegare sul dough (ci hanno raccontato che in Turchia, dove si chiama “ayran”, lo preparano anche frizzante!) e sull’acqua sigillata.
Arriva un piatto unico: ci portano tanto riso con zafferano e un piccolo pesce abbrustolito, forse sulla brace. Siamo davvero sorpresi, ci spiegano che l’università ha fatto un accordo con il ristorante perché ci sia pesce almeno una volta alla settimana; il ristoratore lo fa venire dal Mar Caspio. Pilucchiamo per buona creanza, ma ci rivolgiamo particolarmente al riso, alle mele ed ai pistacchi, poiché la carne tigliosa del pesce non era molto invitante.
Incontro con il Prefetto
Dopo un paio di ore di riposo nel nostro appartamento, per altro necessario non tanto per il jet lag, ma per la notte quasi del tutto saltata, eccoci pronti di nuovo. Questa volta in giacca, ma senza cravatta, avendo memorizzato il suggerimento di Farbod.
Arrivano a prenderci due colleghi dell’università e in dieci minuti raggiungiamo in auto l’edificio dove risiede il Prefetto della città di Shahrood che ci riceve con grande gentilezza, subito è servito il tè. In breve illustriamo quanto deciso con il Rettore; il Prefetto approva le quattro aree , individuate dagli universitari, su cui effettueremo la ricerca dei qanat: Shahrood, Biyar Jormand, Torud e Miandasht. Ci racconta alcuni dettagli: i qanat che si congiungono in Shahrood provengono dalla zona a valle delle montagne al confine con il Turkmenistan, quello a vari rami di Biyar Jormand è ai margini del deserto vicino alla cittadina, mentre quello di Torud ha permesso la nascita di una oasi all’inizio del Deserto del Kavir, che poi si prolunga arido per centinaia di chilometri quasi fino a Yazd, dove c’è un museo dei qanat. Infine ci dice che l’ultimo qanat, quello di Miandasht, non è in buone condizioni; lì però vi sono i resti di un caravanserraglio che era una tappa importante lungo la via della seta.

Miandasht: torre laterale del caravanserraglio (foto A. Ferrari)
Ne ho approfittato per fare un po’ di sfoggio di quel che avevo letto a casa prima di partire. Spiego che il mio entusiasmo nel recarmi per la prima volta nel deserto è stato anche influenzato dal grande maestro sufi Bayazid Bastami che aveva scritto: “Nessuna luce brilla più della luce del silenzio”. Il Prefetto si è molto compiaciuto della citazione, ci ha suggerito di visitare la vicina cittadina di Bastam, dove il maestro nacque ed ha sottolineato come per i persiani l’ospitalità sia sacra e pertanto è per lui un piacere poterci aiutare nel nostro soggiorno e nelle attività che faremo in Iran. Abbiamo avuto la sensazione di aver incontrato un uomo di cultura, molto orgoglioso del suo Paese e realmente pronto a supportare il nostro lavoro, come dimostrerà qualche giorno dopo.

Scorcio del Deserto del Kavir poco prima di giungere a Torud (Foto A. Ferrari)
La prima giornata termina in maniera gradevole: dopo la cena siamo stati invitati a rilassarci nella piscina dell’università appena inaugurata. Verso le ventuno entriamo nell’edificio; siamo solo noi italiani e due docenti iraniani, non eravamo attrezzati con i costumi e pertanto non abbiamo potuto fare il bagno. Ci raccontano che la piscina viene aperta la mattina e la sera solo per gli uomini, il pomeriggio, per tre ore, solo per le donne. Chiacchieriamo sulle attività da realizzare e ci chiedono della società italiana, ovviamente viene offerto l’immancabile tè, poi c’è una novità di stagione, alcuni melograni maturi. Uno degli ospiti ci insegna un’opzione ingegnosa per evitare di sporcarsi nell’aprirli: il frutto si comprime con forza, ruotandolo, su un tavolo o comunque su una superficie liscia e resistente; all’interno del frutto i grani si rompono e il succo si addensa nella parte compressa; poi si fa una piccola incisione sulla buccia del melograno con il coltello e da essa si sugge il nettare rosso, veramente squisito.
Inizia la nostra missione scientifica
Durante gli incontri preliminari, rispondendo alle domande dei colleghi abbiamo precisato le attività che ci ripromettiamo di effettuare per poi poter scrivere da una parte rapporti scientifici sui qanat studiati, dall’altra documenti potenzialmente d’interesse per le autorità locali.
Dal tempo dell’antica Persia l’acqua è sempre stata la risorsa centrale nel rapporto fra l’uomo e l’ambiente, il fattore abilitante per lo sviluppo del territorio. Controllare le risorse idriche ha significato poter far nascere oasi o villaggi, poter far crescere le città, favorire vie di comunicazione e percorsi commerciali. L’acqua era dunque una componente di potere, ma anche uno strumento per garantire un’equa distribuzione delle opportunità; era vero nell’antichità e, nelle zone più aride, lo è anche ora.

Cisterna di contenimento dell’acqua alla Centrale Idrica di Shahrood (Foto Pietro Ragni)
Vista l’importanza dei qanat per l’Iran la nostra ricerca ha due obiettivi principali: definire gli aspetti idrologici e idrogeologici dell’area studiata, al fine di una possibile modellazione numerica delle falde acquifere a cui sono stati collegati i qanat, per migliorare la funzionalità di questi sistemi di raccolta delle acque. Il secondo obiettivo è quello di approfondire lo sviluppo e l’importanza di questi acquedotti nel tempo e nel contesto sociale ed economico delle aree di riferimento e per questo si studierà anche la concentrazione del radon nell’acqua fornita alla popolazione e nell’aria di alcuni pozzi dei qanat.
Alcune di queste misure sono state eseguite direttamente durante la visita delle aree dei qanat, per esempio la georeferenziazione, la misurazione della profondità di alcuni pozzi, la mappatura dei rami del qanat, la struttura geologica del terreno, la misura di parametri fisico-chimici (temperatura, elettroconduttività, ph) ed anche la concentrazione del radon nell’acqua al mahzar. Faccio presente che alla fine ci concentrammo su tre aree, poiché, dopo la visita effettuata, abbiamo scartando Miandasht per le cattive condizioni del suo qanat.
Altri dati sono stati ricavati durante le due missioni successive, ricuperando i semplici strumenti collocati in situ e registrando i dati ottenuti. Si trattava di data-logger (temperatura ambiente, mm di pioggia settimanale, presenza e velocità del vento, ecc.) e dei rilevatori del radon con elettreti, per valutare la concentrazione del radon nell’aria dei pozzi verticali.

Data-logger posizionato sulla ringhiera presso una vasca della centrale idrica di Shahrood (Foto A. Ferrari)
Misura della concentrazione del radon e risultati scientifici
Per quanto riguarda il radon su Tutti Ventitrenta scrissi nell’aprile 2021 un breve articolo per spiegare le sue caratteristiche. In estrema sintesi è un gas radioattivo che può essere inalato o ingerito dall’uomo in locali chiusi e può essere dannoso in particolare per le prime vie aeree; WHO indica il radon come il secondo agente che può causare il cancro polmonare, dopo il fumo delle sigarette.
Nei qanat ho rilevato la concentrazione del gas da una parte nell’acqua per usi potabili dalla popolazione e dall’altra nell’aria dei pozzi, che possono essere equiparati ad un “locale sotterraneo chiuso”. Il primo studio avviene direttamente su un campione di acqua prelevato al mahzar o nel condotto, per cui fu effettuato direttamente in Iran entro poche ore dopo il prelievo. La seconda misura necessitava due letture, a distanza di circa sei mesi fra esse, dei rilevatori calati e lasciati sospesi nei pozzi (vedi figura a seguire). Proprio per realizzare queste misure siamo tornati due volte nel 2009 nei tre luoghi selezionati.
Mi piace ricordare l’ingegno con cui il nostro tecnico dell’Istituto, Roberto, disegnò e poi realizzò il supporto con i due alloggi; esso poi mi ha permesso di montare i rilevatori in Iran per effettuare la misurazione di concentrazione del radon in aria nei pozzi verticali profondi. Il valore era importante da sapere perché i moqqani passano tanto tempo all’interno di quei pozzi o al fondo, dove c’è il canale.

Supporto con due rilevatori per radon calato in un pozzo di qanat (Foto Pietro Ragni)
I risultati del nostro lavoro sono stati: la proposta di un modello concettuale idrogeologico preliminare del flusso e del drenaggio delle acque sotterranee dai qanat per migliorare l’approvvigionamento idrico; le indicazioni circa le problematiche poste dal radon e alcuni suggerimenti per inserire i qanat in possibili percorsi di attrazione culturale-turistica, quando il turismo in Iran sarà incrementato. Questi risultati, a prescindere dagli articoli scientifici, sono stati presentati alle autorità locali nel 2009 per eventuali opportune decisioni e poi, aggiornati, sono stati comunicati nel 2017 a Yazd effettuando una lezione su invito di cui parleremo nell’ultima puntata.
Il qanat di Shahrood: la centrale idrica
La provincia di Shahrood è situata nell’Iran orientale, tra il margine settentrionale del Dasht-e-Kavir (Deserto del Kavir) e i monti Alborz (o Elburz in persiano) orientali, nella circoscrizione amministrativa di Semnan. È questa una delle aree più interessanti per lo studio dei qanat, sia per la loro diffusione, sia per la loro arcaicità e la profonda interazione con la popolazione locale, che ancora ne trae sostegno per l’economia e per l’approvvigionamento idrico. La città, posta a circa 1.300 m di altitudine in un ampio altipiano, aveva, nel 2008, una popolazione di oltre 135.000 abitanti ed il sistema di qanat provvedeva al soddisfacimento dei fabbisogni di circa un terzo dell’utenza.
Prima abbiamo visitato la Centrale idrica della città, un complesso moderno ed efficace, collegato, nel 1990, tramite quattro nuovi pozzi al preesistente sistema di vari rami dei qanat che giungeva in città. Questa integrazione ha favorito la tutela delle caratteristiche dell’acqua potabile e garantito la continuità nell’approvvigionamento. Nel visitare il sito ci ha accompagnato il guardiano, un signore imponente ed un po’ claudicante. Quando si è presentato Ezio (che già al tempo aveva una sessantina d’anni ed i capelli tutti bianchi), il guardiano ha ignorato noi, ha preso lui per mano e lo ha portato presso il grande serbatoio. Noi restammo un po’ stupiti da un gesto che in Europa sarebbe impensabile, ovviamente facemmo varie foto alla strana coppia con mano nella mano, per poter prendere in giro il nostro caro amico, ma poi gli giurammo di non utilizzarle. Il tecnico, inviato dall’università con la telecamera per registrare le nostre attività, ci spiegò che fra uomini è un senso di riverenza verso una persona anziana quello di prenderla per mano.
Ezio Burri era docente di Geografia presso l’Università di L’Aquila, è grazie al suo entusiasmo che ci siamo innamorati anche noi del fascino del deserto. Molto legato alle figlie ed alla moglie, amava viaggiare e, se possibile, organizzava sempre una visita a grotte o cunicoli. Infatti era un provetto speleologo, più volte volontario per la Protezione Civile, fra l’altro intervenne anche subito dopo il terremoto in Irpinia. Innamorato della sua terra, l’Abruzzo, ci portò con lui in due luoghi magici per effettuare rilevazioni: la Grotta del Cavallone e le Discenderie di Claudio ad Avezzano. Un grande amico, un uomo buono che purtroppo non è più con noi.

Tomba ospitata nell’area della centrale idrica di Shahrood (Foto A. Ferrari)
Il guardiano ci ha tenuto a portarci a vedere la tomba di un Mullah locale, conservata in una zona con tanti alberi all’interno della Centrale, dicendoci che riteneva che lo spirito del religioso morto salvaguardasse l’affluenza dell’acqua che serviva per la vita della popolazione.
Durante la visita abbiamo posizionato un data-logger sulla ringhiera prospiciente la vasca più grande della Centrale. Poi ho fatto il prelievo di una piccola quantità dell’acqua dalla vasca ed ho montato in diretta il dispositivo con il rilevatore ad elettrodi per il radon. Dopo due giorni ho potuto rilevare che la concentrazione del radon nell’acqua era molto bassa. Per effettuare un raffronto, il valore era minore di quello che troviamo in media nell’acqua potabile di Roma; valore, per altro, del tutto innocuo.

Avvio la misura della concentrazione radon nell’acqua della centrale idrica di Shahrood; l’operatore che mi riprende è un tecnico dell’università (Foto Pietro Ragni)
Il qanat di Shahrood: i rami di captazione
Il giorno successivo siamo stati accompagnati nell’ampia area dove, nel tempo, si è sviluppata l’opera idraulica dei vari rami del qanat, che ha uno sviluppo orizzontale di circa 25 km in una piana alluvionale limitata a nord-nord ovest dai rilievi del monte Shahvar (3945 m), a sud dai Monti Tapal (2815 m), entrambi compresi nella catena dei Monti Alborz, ricca di scisti, arenarie e calcari. Queste montagne erano care alla mitologia poiché si immaginava che ospitassero un profeta dello Zoroastrismo, l’antica religione persiana, nata nel VI secolo a.C., che adorava il dio creatore Mazda.

Alcuni imbocchi dei pozzi di uno dei qanat di Shahrood dismessi (Foto Pietro Ragni)
In questa area abbiamo ritrovato ben visibili tracce di diversi qanat abbandonati, che sembrano essere stati realizzati in periodi diversi per drenare le acque provenienti dai due citati gruppi montuosi; si tratta dell’area principale di ricarica idrica poiché questi rilievi fermano le correnti umide provenienti dal Mar Caspio, favorendo le precipitazioni che poi si riversano sull’altipiano iranico.
Sono invece in funzione ancora vari rami del qanat, costruiti in tempi diversi, per captare l’acqua da vari punti della falda; essi sono collegati all’ultima parte del condotto, che poi porta l’insieme dell’acqua così raccolta nel grande serbatoio e nella cisterna della centrale da cui poi l’acqua è offerta alla cittadinanza. La portata media del qanat di Shahrood in funzione è di circa 120 L/s, con un regime idrologico abbastanza stabile durante tutto l’anno; le portate maggiori si registrano in primavera, mentre le minime a fine gennaio.

Rinforzo di pietrisco dell’imbocco di uno dei pozzi dei qanat di Shahrood in funzione (Foto Pietro Ragni)
Abbiamo notato che molti dei pozzi ancora attivi sono stati modificati all’imbocco con la costruzione di un anello di pietrisco compattato, in modo da evitare il collasso della terra all’interno del pozzo stesso; alcuni di questi pozzi modificati hanno anche un coperchio, sempre in materiale litico, per essere più protetti.