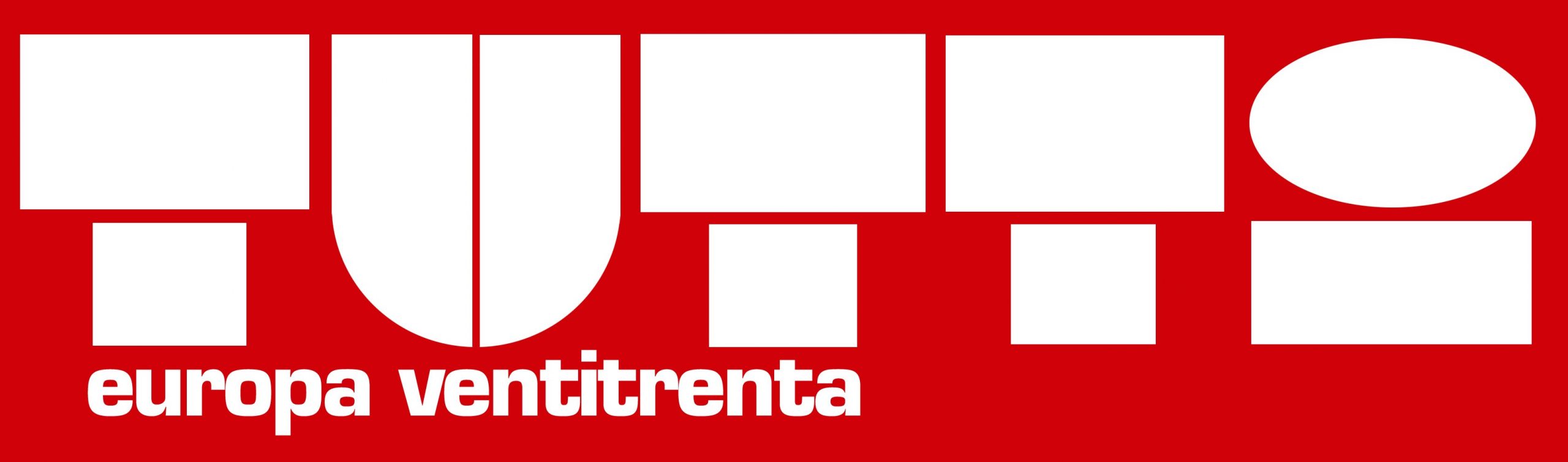Partire dai territori per invertire la rotta contro i cambiamenti climatici è l’espressione più abusata dalla politica negli ultimi anni quando si parla di eventi improvvisi. L’abuso, tuttavia, ha una sua ragion d’essere perché è nei territori che si conquista il consenso per ambire poi ad altri livelli. L’Italia ha adottato la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, ma non riesce a dargli il vigore necessario per evitare disastri e calamità. Evidentemente bisogna intendersi anche bene sulle parole. Disastro equivale più o meno a sciagura, mentre per calamità si intende un evento funesto. Il Paese, per fortuna, non ha costanza di questi eventi, ma negli ultimi quindici anni ne ha affrontato diversi. Avvenimenti meteo che hanno colpito tutte le Regioni con esiti differenti, aggravando, in molti casi, situazioni già insoddisfacenti.
Il Rapporto ASviS
Il recente Rapporto sui Territori dell’Associazione per lo sviluppo sostenibile – ASviS- ha indicato le maggiori criticità con cui gli italiani fanno i conti. Sono conti amari conseguenti principalmente alla “incapacità di usare le risorse economiche disponibili” dice Enrico Giovannini, Presidente dell’ASviS. Il Rapporto documenta come Povertà, Acqua e sistemi idrici e Qualità degli ecosistemi terrestri siano gli anelli deboli di una successione territoriale che unisce milioni di persone. Sono capitoli emergenziali che rimandano a una scissione dell’azione tra centro e periferia. Gli anni dal 2010 al 2023 sono stati i più negativi. Le Regioni non sono andate avanti verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile provocando una discrepanza tra programmi e interventi concreti. I quattro macro capitoli sono peggiorati ovunque allontanando uno dei Paesi centrali dell’Europa da quella visione sulla sostenibilità ambientale e sociale che è la vera cifra del futuro. Curioso che ci siano Presidenti di Regione che reclamino più risorse quando non riescono a spendere quelle che già hanno in casa. E quando la politica non riesce a fare i conti con se stessa, per capire perché le visioni non si traducono in realtà, ci sono i numeri.

Di Comune in Comune
L’Italia ha 75 miliardi di euro in base a un Accordo di Partenariato con l’ Ue, ma finora ha speso poco più del 10%. Il sistema della spesa è ancora troppo farraginoso e si porta dietro lentezze strutturali che nemmeno davanti a fondi straordinari si riescono a eliminare. Sempre il Rapporto ASviS ha preso in esame alcune buone pratiche di Comuni messe in atto da sindaci della Rete dei Comuni sostenibili. È una buona citazione – in antitesi alla retorica politica – dato che la territorialità delle politiche ambientali è quella che i cittadini percepiscono per prima. I sindaci sono storicamente il primo modello di impegno nelle istituzioni ed è il momento di dare loro più poteri nell’organizzare interventi ispirati alla sostenibilità ambientale e sociale. Sulla carta possono fare meglio delle Regioni che spesso sono gli epigoni della burocrazia centrale. Ma se dovessero fallire, i cittadini saprebbero subito chi e perché non li solleva da ansie ambientali e sociali. Il Comune, alias i sindaci non sono una dimensione astratta, ma l’istituzione parlante che deve ascoltare e saper rispendere. Comune dopo Comune si può realizzare quello che sinora è stato complicato mettere in pratica. Molto dipende dagli elettori e dalla volontà di chi viene eletto. Però è un dato di fatto che i cambiamenti climatici provocano anche nuove disuguaglianze nel corpo sociale: dalla salute, alle abitazioni, ai costi per l’energia, alla mobilità. Perché allora non riconoscere nei poteri e nei sindaci (primaria organizzazione politica) la forza per mettere le “radici della sostenibilità” in condizione di dare frutti ? Accanto ai sindaci ci sono imprese, associazioni, volontari, parrocchie con funzioni di stimolo e di controllo. Il successo non è scontato, ma può essere di conforto a tutti noi ogni volta che sentiremo dire “partire dai territori “contro i cambiamenti climatici.