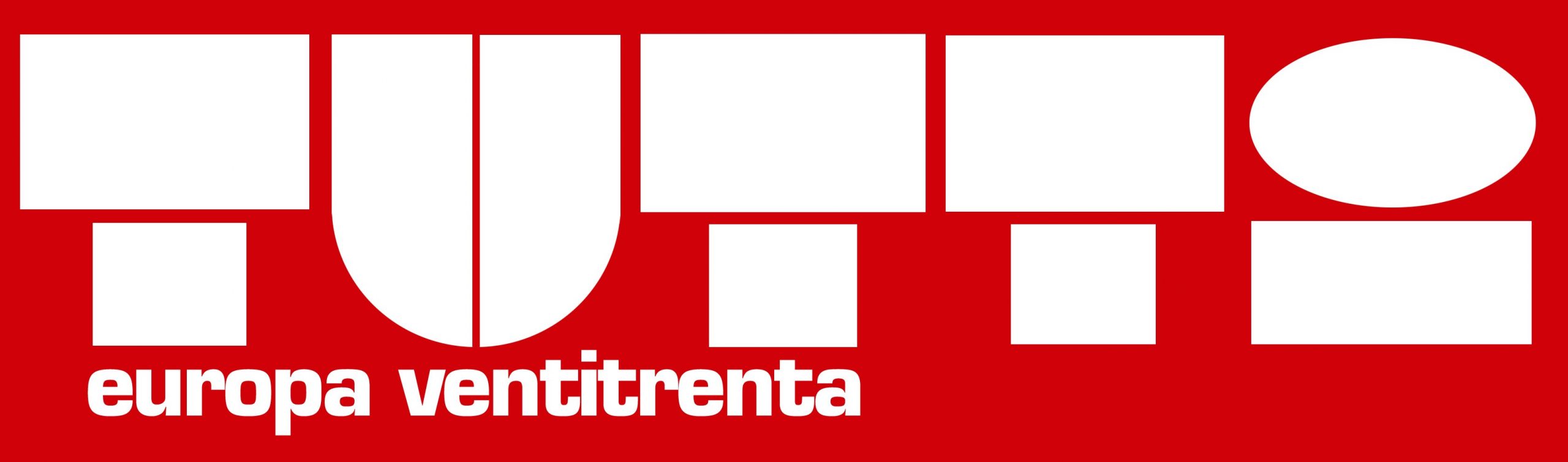La dinamica dei rapporti tra i cittadini, i membri di una comunità umana ed il potere, cioè i governanti, percorre e caratterizza in pratica la vita degli esseri umani, dalle tribù dei Sapiens alle moderne nazioni. Anzi si potrebbe dire che la limitazione dei poteri del sovrano verso tutti coloro che erano sottoposti alla sua autorità, ha costituito uno dei suoi aspetti fondamentali.
La Magna Charta – pur senza successo – costituì già nel 1215, uno dei primi tentativi di contenere i poteri del sovrano inglese, sia verso la sua aristocrazia che verso i suoi cittadini. In ogni epoca della storia ci sono stati governanti e governati: Re, Signori, Principi, e governi quelli che dovrebbero essere l’espressione dei popoli nelle repubbliche e nelle democrazie.
Per evitarne gli abusi e garantire i diritti dei governati, nell’epoca moderna sono state scritte le Costituzioni come primarie regole della struttura e del funzionamento degli Stati. In molti paesi sono anche stati adottati speciali sistemi giuridici per regolare i rapporti tra il potere esecutivo, le sue amministrazioni e i cittadini, come testimonia il diritto amministrativo di Francia, Germania e Italia.
Tuttavia il rapporto tra sudditi o cittadini e l’esercizio del potere dello Stato, ha subito, e continua a subire, profondissimi cambiamenti che si sono tradotti, in moltissimi casi, in violente ribellioni, allorquando l’esercizio del potere, invece che essere difesa della comunità veniva considerato esercizio di sopraffazione, abuso e prepotenza. Quando ciò si verificava – ed è successo spessissimo nella storia – il nome dei governanti diventava tiranni, e le comunità reagivano con sanguinose rivolte o colpi di stato oppure uccidendo i tiranni. È altrettanto vero che la storia ci ha mostrato anche esempi di conflitti con il potere attraverso procedimenti non violenti.

La statua del Mahatma Ghandi
Tutti ricordiamo i grandi rivolgimenti negli assetti degli Stati ottenuti da Ghandi e Mandela, eppure la non violenza è molto più antica. Il Console Menenio Agrippa, quasi cinquecento anni prima di Cristo, fu chiamato a risolvere il conflitto tra patrizi e plebei nella repubblica di Roma. Come è noto la plebe romana si era ribellata alle prevaricazioni e alla protervia del patriziato romano, organizzando una secessione sull’Aventino. Probabilmente il primo sciopero della storia! Agrippa, che era un patrizio romano, riuscì a risolvere pacificamente il conflitto attraverso il suo famoso apologo, che spiegava che un corpo sociale era formato dalla testa – i patrizi – ma anche dalle membra – i plebei – e che senza una delle due componenti la Repubblica romana non avrebbe potuto funzionare. Questo antichissimo esempio dimostra però che il conflitto contro il potere era stato risolto, non sulla base di principi astratti, ma dell’essenziale bisogno dei ricchi del lavoro di tutti quei poveri, che fornivano loro servizi essenziali come i fornai, i macellai, i fabbri e i falegnami.
Non basterebbe un lunghissimo articolo, un saggio o neanche un libro per affrontare seriamente il problema delle rivolte, del conflitto dei cittadini con il potere, in una prospettiva storica. L’umanità ha dovuto attendere la secessione delle colonie britanniche dell’America nel 1783, e finalmente la Rivoluzione Francese, che sancì definitivamente i diritti dell’uomo e del cittadino, nel 1789. Inutile dire che queste due conquiste del genere umano non furono ottenute attraverso pacifiche proteste, ma con conflitti e lotte molto sanguinose. Luigi XVI, e una gran parte della nobiltà francese, furono ghigliottinati perché rappresentavano un potere divenuto inaccettabile per i loro sudditi.
La storia dell’uccisione di Imperatori, Re, Sovrani, è molto lunga. Ipparco, tiranno di Atene, insieme a suo fratello Ippia, venne assassinato da due aristocratici ateniesi, Armodio e Aristogitone (514 A.C.). la vicenda di Giulio Cesare, assassinato da Bruno e Cassio nel 44 A.C. è talmente nota da non aver bisogno di commento. Alessandro De Medici, fece la stessa fine ad opera di un parente, Lorenzino (1537), e furono ugualmente assassinati il Re di Francia Enrico IV (1610), Luigi XVI nel 1793, a seguito della Rivoluzione francese, ma anche Marat, uno dei tre fautori di quella rivoluzione, considerato come traditore di quegli ideali. Nel 1881, lo Zar Alessandro II fu ucciso da una bomba, e l’attentato era stato organizzato dalla grande rivoluzionaria Sofia Perovskaja esponente dell’organizzazione rivoluzionaria Narodnaja Volja. Le gesta degli anarchici regicidi sono molte, perché facevano parte di una visione politica che si opponeva per principio al potere. Ne fece le spese il re d’Italia, Umberto I, assassinato nel 1900 dall’anarchico Gaetano Bresci, come anarchico era anche Gavrilo Princip, assassino del Granduca Francesco Ferdinando (1914) erede al trono austro ungarico. La Rivoluzione bolscevica in Russia causò il massacro dello Zar Nicola II e della sua famiglia, ad Ekaterimburg (1918). Noi italiani, non abbiamo certamente dimenticato l’uccisione di Benito Mussolini nel 1945, ad opera dei partigiani italiani.
L’era della decolonizzazione è ovviamente piena di rivolte e di uccisioni di leader politici, sia quelli che rappresentavano i colonizzatori, che molti altri che avevano collaborato con loro o che si erano manifestati come nuovi tiranni. Molto più vicini a noi sono l’assassinio di Saddam Hussein ad opera di un tribunale iracheno a seguito della caduta del suo regime (2006) e quello di Gheddafi nel 2011 ad opera del Consiglio libico nazionale di transizione.
Mi si perdonerà di averne omessi tanti altri, e di aver “mischiato” assassini politici operati da diversissimi attivisti o gruppi, per ragioni anche molto diverse, perché certamente il Granduca Francesco Ferdinando e il nostro Re, Umberto I, non potevano essere certamente qualificati come tiranni, alla stregua degli Zar, di Gheddafi o di Saddam Hussein. È andata bene a Hitler e Stalin, per la fortuna del primo che non è morto a seguito dell’attentato di Von Stauffemberg. Descrivere ma sono tra i pochi tiranni a non aver cessato la loro nefanda gestione del potere a causa di pallottole o bombe
Molte Costituzioni parlano delle rivolte di popolo, delle ribellioni, in molti modi diversi che sarebbe lunghissimo descrivere. Chi volesse approfondire potrebbe leggere il bellissimo saggio di Gianluca Serra “Sul “diritto” di ribellione. Riflessioni a margine delle recenti sollevazioni popolari dal Nord Africa al Golfo Persico, con particolare riferimento al caso della Libia” (Costituzionalismo.it). Nel diritto internazionale molto si è discusso sul diritto di ribellione e quindi dell’uso della violenza, che molti studiosi riconducono al principio di autodeterminazione dei popoli, resta però il problema che la Carta dell’ONU e molti principi del diritto internazionale attuale, sono stati costruiti proprio per evitare la violenza, nella soluzione di conflitti. Ecco perché è difficile prevedere e regolare strumenti violenti, anche se questi sono utilizzati per l’affermazione di diritti umani anche quando essi vengano abusati e violati. In poche parole sarebbe sempre la comunità internazionale, l’ONU, a dover adottare strumenti di peace enforcing o di peace kipping, per evitare il ricorso alla violenza di individui o gruppi.
È interessante notare che i nostri padri costituenti avevano discusso, su proposta della componente comunista rappresentata da Fausto Gullo, di inserire un comma 2 all’art. 50 che formulava il diritto di ribellione: “Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi. Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino”. Prevalse invece la visione del grande costituzionalista Costantino Mortati, che ottenne che il detto comma 2 non fosse aggiunto al documento costituzionale.
Il ragionamento di questo grande giurista è talmente chiaro che val la pena di riportarlo, come fa l’articolo sopramenzionato di Gianluca Serra. “Noi abbiamo creato un insieme di garanzie atte a preservare dalla violazione dei diritti anche di fronte ai supremi organi dello Stato. Ora quando si verifichi l’ipotesi che tutte queste garanzie siano esaurite e quando la stessa Corte costituzionale abbia convalidato con la sua sentenza l’atto arbitrario della pubblica autorità, in questo caso il cittadino – secondo il significato della disposizione proposta – […] deve ribellarsi. Intesa in questo senso la disposizione, ci si deve chiedere: è opportuno che essa sia inserita nella Costituzione? […] Non è al principio che noi ci opponiamo, ma alla inserzione nella Costituzione di esso, e ciò perché a nostro avviso il principio stesso riveste carattere metagiuridico, e mancano, nel congegno costituzionale, i mezzi e le possibilità di accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima. Siamo condotti con questa disposizione sul terreno del fatto, e pertanto su un campo estraneo alla regolamentazione giuridica. Si è detto che questo articolo potrebbe avere un valore educativo, e questo è vero. Ma bisogna allora stabilire se la Costituzione debba essere un testo di legge positiva oppure un trattato pedagogico. In riferimento al carattere di testo legislativo che la Costituzione deve rivestire, […] riteniamo che non sia opportuno sancire un tale principio nella Costituzione”.
Come si vede Mortati non nega che in presenza di gravi abusi dei diritti cui gli organi dello Stato, e in particolare quelli giurisdizionali non avessero potuto dare risposta, non resterebbe che la ribellione. Però in una logica giuridica perfetta e indiscutibile ci sta dicendo anche che il diritto non può regolare qualcosa che non appartiene al diritto ma ai fatti della storia. Comunque il mio scopo, in questo scritto, era soltanto quello di mostrare come le lotte di popoli, o gruppi fautori della libertà, hanno spesso fatto ricorso alla violenza per sopprimere sovrani, leader politici ed altre figure che rappresentavano per loro l’esercizio di un potere ingiusto, illimitato ed inaccettabile.

Il muro di Berlino
Con la caduta del muro di Berlino, molti avevano pensato che la democrazia e i diritti stavano diventando, o sarebbero certamente diventati, la forma di potere alla quale prima o poi, tutti i paesi del mondo sarebbero giunti, tanto che, con la fine del comunismo, Samuel Huntington aveva potuto parlare della ‘fine della storia’. Abbiamo purtroppo constatato che non è andata così. Non solo è emerso Putin, certamente un tiranno di questo secolo, ma Kim Jong-un, è l’ultimo di una dinastia di tiranni al potere nella Corea del Nord da cinquant’anni, Khamenei, successore di Khomeini, ne ha continuato la tirannia che dura in Iran da più quaranta anni, Nicolas Maduro, successore di Chavez, è il dittatore del Venezuela, e molte primavere arabe hanno portato di nuovo al potere dittatori e tiranni come Al Sisi in Egitto e Bashar Assad, benché oggi deposto, in Siria e nel continente africano abbondano ancora tiranni e tirannelli. Infine non sarebbe forse ingiustificato definire anche Xi Jinping un dittatore, soprattutto per la svolta autoritaria della quale è stato il protagonista nel suo paese.
I dittatori e i tiranni sono certamente molto diversi, ma sono accomunati da alcuni elementi, come la repressione del dissenso attraverso pratiche violente di imprigionamento, tortura e omicidio, la concentrazione su una o poche persone dei poteri dello Stato, il controllo dell’economia e della ricchezza, e soprattutto la negazione della giustizia come potere indipendente. Inoltre è sempre la concentrazione del potere che dà a dittatori e tiranni la tentazione dell’uso della forza nei rapporti internazionali, come oggi è visibile a tutti.
Però fino a qualche anno fa, il controllo dei cittadini da parte di dittatori e tiranni si esercitava in modo, per così dire tradizionale, attraverso intelligence, polizie politiche e altri metodi che potremmo definire ‘fisici’, che sono anche molto visibili e chiaramente identificabili. La repressione e il condizionamento erano perseguiti in sostanza con fruste e bastoni, così come la guerra, qualsiasi guerra, continua ad essere condotta non più con le spade, certamente, ma con bombe, droni, aerei e carri armati, che colpiscono gli uomini nella loro dimensione fisica. Possiamo contare morti e feriti, ma siamo sempre nella stessa logica del conflitto tra due tribù di sapiens, che magari si affrontavano a sassate.
L’Intelligenza Artificiale stravolge invece completamente le cose, non solo perché opera sulla mente delle persone ma anche perché la produzione dell’informazione è concentrata su pochissime grandi aziende, su pochissimi imprenditori, che ne posseggono i segreti della utilizzazione impostando e gestendo i famosi “algoritmi”. Persino le armi nucleari non sono mai state utilizzate alla fine, perché non ci sarebbe mai stato un vero vincitore, e i danni causati sono incontrollabili e infinitamente maggiori di spade e bombe tradizionali.
La proprietà e l’uso dei social media è concentrato nelle mani di un numero piccolissimo di persone come Elon Musk, Jeff Besos, Mark Zuckerberg, e pochissimi altri, che naturalmente finanziano gli sviluppi della comunicazione internet e dell’Intelligenza Artificiale. È significativo però notare che in previsione dell’elezione di Trump, anche Zuckerberg e gli altri si siano alleati alla nefanda politica di Trump e Musk.

Intelligenza Artificiale
Da quasi un anno sto studiando – come posso – l’Intelligenza Artificiale: quasi tutti dicono le stesse cose, e il migliore studio critico in materia, resta quello di Kate Crawford “Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell’IA” (ed. Il Mulino – 2021). Chi non avesse il tempo di leggere questo stupendo studio, può trovarne la sintesi su YouTube. Questa grande studiosa e moltissimi altri, più o meno qualificati, ci dicono le stesse cose sulla incredibile pericolosità della IA. È ovvio che ogni strumento umano, da un coltello in su, può essere utilizzato per il bene o per il male. Ma l’IA ha il vantaggio, o l’incredibile e perversa capacità di arrivare direttamente a ciascuno di noi, nelle nostre tasche, in un qualsiasi smartphone. Può diffondere informazioni e analisi vere o completamente false, comunque utilizzabili dal padrone non solo per farci comprare qualche oggetto, ma per farci pensare nel modo che vuole lui.
Se si considera che i più grandi finanziamenti per la ricerca sulla IA sono stati offerti dalle agenzie di intelligence americana e dagli apparati della difesa, non mi sembra ci sia bisogno di commento. Molti sarebbero i modi per contrastare questo pericolosissimo e invasivo strumento di condizionamento “omeopatico” delle persone e delle comunità. Si potrebbe lanciare una campagna di boicottaggio cancellando X, Facebook ed altri social media, incluso TikTok, del quale si sta appropriando sempre Musk, ma questo comporterebbe una azione, una coesione internazionale che appare oggi molto difficile in un mondo che viaggia sugli smartphone e in una fase di decadenza culturale, civile e sociale del mondo occidentale, che è quella descritta in modo tanto straordinario quanto deprimente, dal grande sociologo francese Emmanuel Todd “La sconfitta dell’Occidente” (Ed. Fazi Editore – 2024).
Una resistenza non violenta a questo gravissimo e incontrollabile pericolo sembra quindi difficile, se non impossibile, anche per gli enormi strumenti di pressione che potrebbe incontrare dai nuovi padroni del mondo. Mi permetto quindi in questo caso di dissentire dalla visione, alla fine sempre ottimistica e piena di speranza di uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo, Yuval Noah Harari, che nel suo più recente libro Nexus. Breve storia delle reti di informazione dall’età della pietra all’IA (2024) e nei suoi molti scritti, conclude sempre facendoci notare, da grande storico, che l’umanità ha sempre trovato, prima del baratro, la forza per reagire e sopravvivere. Io invece penso tristemente che forse un giorno ci renderemo conto di essere costretti a ritornare al regicidio, per uccidere i padroni dell’Intelligenza Artificiale, tagliando la testa del serpente.
Non si tratterebbe molto probabilmente di rivolte e rivoluzioni, ma piuttosto del gesto imprevedibile, ma sempre più diffuso, di quelli che i più superficiali dei nostri giornalisti, chiamano ‘lupi solitari’. A loro vengono attributi, in modo semplicistico e sensazionalistico molti atti di terrorismo, e ci si meraviglia – sempre stupidamente – che siano persone comuni, che magari non avevano mai fatto prima niente di male, mentre si dovrebbe riconoscere, come ci spiega Gilles Kepel, nei suoi grandi studi del mondo islamico, che questi lupi non sono affatto solitari, ma l’espressione di ideologie del dissenso che si sono radicalizzate generando di fatto una lotta al potere, diffusissima e incontrollabile, e quindi difficilissima da evitare e prevenire.
A mali estremi, estremi rimedi. È un vecchio detto, ed è triste dover constatare che forse solo il regicidio di questi nuovi padroni, senza che possano sapere chi e quando potrebbe attentare alla loro vita – magari anche persone a loro vicine – potrebbe far loro paura, sollevando così anche l’interesse dell’opinione pubblica – come è avvenuto per l’attentato a Trump – che non va a votare in gran numero nelle grandi democrazie, sulla base del mantra “tanto non cambierà nulla”.